La non libertà dell’espressione umana
David Bello e Alexandre Montagu, "Il capitalismo della creatività: passato, presente e futuro del diritto d’autore", Marsilio 2024
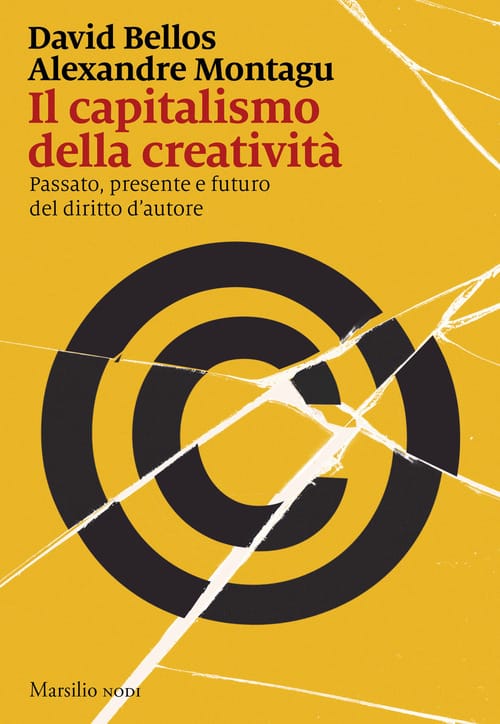
Per la maggior parte delle persone, “diritto d’autore” significa una cosa sola: che gran parte della cultura moderna e contemporanea non sarà libera da costi di licenza o da vincoli di utilizzo finché i nostri nipoti non saranno in pensione. David Bellos e Alexandre Montagu ci conducono alla scoperta dell’invenzione stessa del diritto d’autore.
Sì, invenzione: perché il copyright che oggi impedisce alla maggior parte di noi di fruire liberamente delle opere dell’ingegno non è un principio naturale, ma il risultato di secoli di dibattiti, ritocchi successivi, cause giudiziarie e modifiche legislative. Dietro la sua evoluzione si nascondono storie sorprendenti, fatte di compromessi, manipolazioni e sofismi verbali. Forse non stupirà, ma il moderno diritto d’autore non si fonda su principi o valori realmente al servizio dei creatori, bensì su un linguaggio costruito per tutelare interessi economici e produttivi.
Nato nella Londra del XVIII secolo, il copyright garantiva agli autori e ai loro editori un monopolio temporaneo sulla stampa e la vendita dei libri. Poi si è espanso, inglobando via via nuove forme di creazione: incisioni, spartiti musicali, opere d’arte, teatrali, cinematografiche, musicali, traduzioni, adattamenti, esecuzioni e perfino interpretazioni. Insomma, “chi più ne ha, più ne metta”.
Ma siamo davvero sicuri che tutto questo vada a vantaggio degli autori e degli artisti?
Se ci fermiamo a osservare, scopriamo che la maggior parte dei diritti con valore commerciale non appartiene agli autori, ma alle aziende. Le stesse che, sotto il nobile pretesto dell’“incoraggiamento dell’istruzione”, accumulano diritti infiniti e ricchezze smisurate, nascondendosi dietro parole settecentesche che promettevano di servire il bene pubblico. Così, il diritto d’autore da promessa di libertà creativa è diventato uno strumento di disuguaglianza. I colossi finanziari si fanno pagare licenze pluridecennali per sfruttare i prodotti dell’ingegno altrui, mentre agli artisti restano solo loro stessi.
Nel passaggio dall’economia agricola a quella industriale e poi all’era digitale, il valore dei beni intangibili –idee, immagini, software, musica– ha eclissato quello delle ricchezze materiali, trasformando il sapere in proprietà e la creatività in merce. Un’evoluzione che ha piegato la cultura a fini puramente economici, più che alla diffusione della conoscenza per la crescita collettiva.
Nel mondo antico, il lavoro creativo non era qualcosa da possedere. Nessuno pensava che un’idea potesse essere privata. Gli autori imitavano, si ispiravano, citavano apertamente: l’imitazione era non solo lecita, ma un criterio di valore. Per Aristofane, Terenzio, Cicerone e molti altri, il vero peccato non era copiare, ma non dichiarare le proprie fonti, secondo un codice d’onore che oggi potremmo chiamare semplicemente “rispetto per i lavori altrui”. Del resto, nessuno scrittore, compositore o artista arriva mai a creare qualcosa di completamente nuovo: ogni opera nasce da un intreccio di memorie, di influenze, di idee.
E poi c’è l’estensione del diritto post mortem. L’aggiunta di anni di protezione dopo la morte dell’autore non nacque, come si crede, per tutelare vedove e orfani dei grandi artisti, ma per servire gli interessi immediati del commercio librario. La maggior parte dei libri vende poco e in fretta; altri vendono molto e poi scompaiono. Solo pochi, pochissimi, continuano a generare valore nel tempo. Tra questi ci sono opere complesse – dizionari, enciclopedie, grandi saggi – o libri che trovano tardi il proprio pubblico. Se gli editori avessero perso il controllo su questi testi prima di rientrare dei costi, avrebbero perso gran parte dei loro guadagni. Fu questa la motivazione pratica dell’estensione post mortem: una scelta che, però, ha finito per gettare le basi di enormi fortune nei secoli a venire.
E cosa dire delle opere orfane?
Il 90% dei libri, dei film, delle opere teatrali e delle canzoni del secolo scorso è oggi fuori catalogo, o non più disponibile. Gli editori originali non esistono più, gli autori sono morti, gli eredi introvabili o dispersi. Queste banali realtà rendono spesso impossibile ottenere le autorizzazioni necessarie per ristampare, citare o adattare. Così, quasi tutta la cultura moderna è finita in una sorta di orfanotrofio, da cui solo una minima parte riesce a evadere ogni 1° gennaio.
Ma la vera perdita riguarda la valenza pubblica della cultura, di ogni opera diffusa. E allora, tra le tante, una domanda dovremmo farcela: il termine “pubblicazione” ha ancora senso?
Nel labirinto legale costruito dalle norme sul copyright, il pubblico non ha voce in capitolo. Oggi la “proprietà intellettuale” è diventata una tassa invisibile sulla cultura: sulla lettura, sull’ascolto, sulla visione. Una tassa che si nasconde nel prezzo dei libri, della musica, del cinema, dell’informazione. Ed è impossibile calcolare quanta parte di ciò che paghiamo ogni giorno finisca, in ultima analisi, nelle tasche dei detentori di monopoli quasi eterni, più che nel sostegno degli artisti che tengono viva la cultura contemporanea.
In altre parole, il diritto d’autore è oggi uno dei principali motori di disuguaglianza del XXI secolo. Costringe i Paesi più poveri a trasferire risorse ai più ricchi per poter accedere a libri, film o conoscenza scientifica. E alimenta disuguaglianze anche all’interno dei singoli Paesi, tutelando le aziende più che gli autori.
Persino Thomas Piketty, nel suo celebre "Il capitale nel XXI secolo", non affronta il tema della proprietà intellettuale, pur avendo costruito la sua fortuna proprio su quell’argomento. La maggior parte degli scrittori, compositori, artisti e programmatori, invece, accumula capitali minuscoli, quando non inesistenti. Il diritto d’autore contribuisce così ad ampliare il divario tra la ricchezza di pochi e la povertà di molti: la stessa dinamica che Piketty analizza per l’economia globale.
E oggi, nell’era dell’intelligenza artificiale, la domanda torna a farsi urgente: dove si fermerà questa espansione? Le IA producono testi, immagini, traduzioni senza intervento umano: ma di chi sono questi contenuti?
Il libro non offre risposte semplici, ma accompagna il lettore in un viaggio lucido e appassionante, in cui ogni certezza sul “diritto” e sulla “creatività” viene ribaltata. Bellos e Montagu ci ricordano che la storia del diritto d’autore non è la storia della libertà, ma quella di un potere che, travestito da tutela, ha trasformato la creatività in capitale e l’immaginazione in proprietà.
Una lettura necessaria per chiunque voglia comprendere come la cultura sia diventata un campo di battaglia economico, dove si tracciano confini e si erigono barriere, per chiedersi, infine, se e come potremo ancora riprendercela.
Beatrice Carrara

Beatrice Carrara
Aree: Sostenibilità, Cultura
Beatrice Carrara è storica dell’arte e studentessa magistrale in "Comunicazione del patrimonio" nel corso "Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale" presso l’Università degli Studi di Bergamo. Si occupa della redazione di bilanci sociali e di sostenibilità e di attività di ricerca sul mercato dell’arte.
