Eremiti ornamentali e nani da giardino: l’artista come decorazione sociale
Gordon Campbell, "The Hermit in the Garden", Oxford University Press, 2013
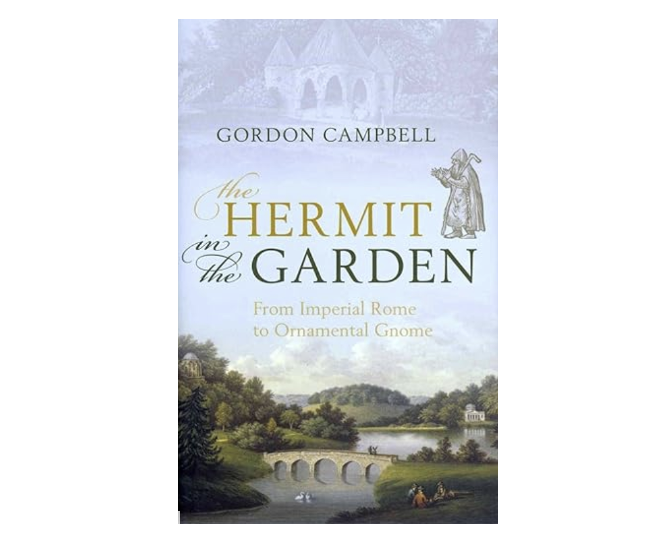
Le persone sono strane. Hai presente l’aristocrazia inglese? Quelli tipo Downtown Abbey, eleganza compassata, poco lavoro e molti diritti. Ecco, probabilmente il nonno di Robert Crawlay, il conte della serie, nella loro tenuta dello Yorkshire aveva anche lui il suo eremita ornamentale. Un prototipo del nano da giardino in carne e ossa, di moda all’inizio dell’800 che veniva ospitato in qualche baracca nel giardino del nobile, viveva in isolamento come ogni eremita che si rispetti ma che compariva ogni tanto senza poter parlare con nessuno se non sé stesso di filosofia.
Per contratto (durata sette anni) non potevano tagliarsi la barba, capelli, unghie e forse lavarsi. Non potevano abbandonare l’area a loro dedicata ma ricevevano cibo. Probabilmente non sempre a sufficienza visto che uno di loro è stato licenziato per giusta causa visto che dopo sole tre settimane lo hanno ritrovato al pub.
Un po’ come l’AI per certi lavori, l’avvento dei nani ha soppiantato la moda e gli eremiti ornamentali hanno perso il loro appeal e si sono ritrovati a cercare nuove specializzazioni. Ma entrambi sono elementi decorativi, kitsch, forme senza sostanza esposte ma escluse.
Ne ha scritto Gordon Campbell in un libro curioso e dalle molte letture.
Ad esempio, ci possiamo vedere un riferimento al rischio che corre l’artista contemporaneo, senza riconoscimento giuridico e, spesso, economico, che è lo stesso dell’eremita e del nano da giardino. Relegato a una posizione decorativa, simbolica, ironica, come il nano, l’artista deve essere visibile ma innocuo. Deve sembrare profondo ma non disturbare, portare critica ma senza conseguenze. L’artista oggi è tollerato, purché rimanga inoffensivo. La sua figura è quella del testimone silenzioso di una società che lo tiene ai margini, che lo accetta solo quando è utile a decorare una facciata culturale, un evento, una biennale, purché non pretenda troppo potere o centralità.
Svuotato del suo potenziale trasformativo, l’artista è spesso costretto a simulare un ruolo politico che in realtà non ha più impatto. È presente nel discorso pubblico, ma in forma di citazione, di citazione della citazione. Ironico, autoreferenziale, post-tutto. Ed è proprio questa condizione di impotenza che lo rende simile al nano da giardino: testimone kitsch di un’epoca che lo ha messo in vetrina ma non lo ascolta. Come il nano, è ridotto a forma, spesso senza sostanza politica o trasformativa e senza neanche la speranza che arrivi il Fronte di Liberazione dei Nani da Giardino a salvarlo.
Franco Broccardi

Esperto in economia della cultura e della sostenibilità, arts management e gestione e organizzazione aziendale, è consulente, membro di cda e revisore di musei, teatri, gallerie d’arte, fondazioni, festival e associazioni culturali.
Si occupa di consulenza e formazione per fondazioni bancarie, istituzioni pubbliche e private in materia in materia di terzo settore, gestione e organizzazione di istituzioni culturali e di mercato dell’arte.
Co-fondatore e partner dello studio Lombard DCA di Milano e fondatore e curatore della rivista ÆS Arts+Economics.
Professore a contratto in Economia del patrimonio culturale presso l’Università degli Studi di Bergamo. Tra le altre cariche è presidente della commissione di Economia della Cultura presso la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, consulente per le politiche fiscali di Federculture, membro della commissione tecnica a supporto del consiglio direttivo oltre che membro del gruppo di lavoro Bilancio sociale di ICOM Italia – International Council of Museums, consulente di ADEI – Associazione Degli Editori Indipendenti.
